Sull’argomento antinutrienti segnalo anche la diretta con il medico funzionale Giorgio Tabarroni, anche lui parte del tea, HealthyWay
E anche la diretta sul più antipatico degli antinutrienti, il glutine
Antinutrienti: i nemici invisibili della nutrizione
Quando si parla di alimentazione e qualità di un alimento, è essenziale comprenderne la composizione nutrizionale e valutare se il suo consumo possa esporci anche ai cosiddetti antinutrienti. In base al suo profilo nutrizionale, un alimento può risultare più o meno adatto ai vari approcci dietetici come quello low-carb o chetogenico e la personalizzazione di una dieta deve tener conto della presenza di antinutrienti e della suscettibilità individuale a questi composti.
Nel corso di questo articolo approfondiremo la distinzione tra macronutrienti e micronutrienti, il concetto di densità nutrizionale e biodisponibilità, e il ruolo degli antinutrienti, con particolare attenzione agli effetti che possono avere sulla salute.
Nutrienti: le fondamenta della salute
I nutrienti sono sostanze essenziali che il corpo necessita per crescere, svilupparsi e mantenere le sue funzioni vitali. Si suddividono in due categorie principali:
Macronutrienti, richiesti in quantità elevate.
Micronutrienti, necessari in quantità minori ma fondamentali per il benessere generale.
Macronutrienti: fonte di energia e struttura
Si chiamano “macro” perché devono essere assunti in quantità maggiori rispetto ai micronutrienti. Infatti, l’unità di misura per questi composti è il grammo, mentre per i micronutrienti si usano milligrammi o microgrammi.
I macronutrienti comprendono:
Proteine → Essenziali per la crescita e la riparazione dei tessuti.
Le fonti proteiche di origine animale (carni, uova) sono particolarmente pregiate perché forniscono tutti gli amminoacidi essenziali in una forma altamente biodisponibile.
Grassi → Forniscono energia a lungo termine e supportano diverse funzioni cellulari.
I grassi animali (presenti in uova, carne e latticini) offrono acidi grassi essenziali e vitamine liposolubili (A, D, E, K) in forme facilmente assimilabili.
Carboidrati → Fonte rapida di energia.
Presenti in cereali, frutta, verdura e legumi, vengono spesso considerati essenziali, ma l’organismo è in grado di produrre autonomamente il glucosio necessario a partire dagli altri macronutrienti.
Acqua → Non fornisce energia, ma è vitale per il trasporto dei nutrienti e per le reazioni metaboliche.
Micronutrienti: supporto essenziale per il corpo
I micronutrienti sono richiesti in quantità minime, ma svolgono ruoli critici per il funzionamento dell’organismo e il mantenimento della salute.
Vitamine → Regolano numerosi processi biologici.
Vitamina B12: Presente esclusivamente in alimenti di origine animale (carne, uova, latticini), è fondamentale per la salute neurologica, la riparazione del DNA e la produzione di globuli rossi.
Vitamina K2: Fondamentale per il metabolismo del calcio, aiuta a rafforzare ossa e denti e previene la deposizione di calcio nei tessuti molli, riducendo il rischio di placche calcifiche nelle arterie e calcificazioni tendinee o muscolari.
Minerali → Essenziali per numerose funzioni fisiologiche.
Ferro: Il ferro eme, presente nella carne, è altamente biodisponibile rispetto al ferro non- eme di origine vegetale.
Calcio, zinco e magnesio: Cruciali per ossa, trasmissione nervosa e metabolismo cellulare.
Densità Nutrizionale
La densità nutrizionale rappresenta il rapporto tra la quantità di micronutrienti essenziali (vitamine, minerali, antiossidanti e altri composti bioattivi) e l’apporto calorico di un alimento. Un alimento è considerato ad alta densità nutrizionale quando fornisce un’elevata quantità di nutrienti benefici a fronte di un contenuto calorico relativamente basso.
Questa caratteristica è fondamentale per la salute e la prevenzione delle carenze nutrizionali, in quanto consente di ottenere tutti i nutrienti necessari senza eccedere con l’apporto energetico. Al contrario, alimenti con bassa densità nutrizionale, come prodotti ultra-processati, zuccheri raffinati e cibi ad alto contenuto di grassi industriali, forniscono molte calorie ma pochi micronutrienti, contribuendo a carenze nutrizionali e squilibri metabolici.
Gli alimenti più densi di nutrienti sono generalmente di origine animale, poiché forniscono proteine complete, minerali altamente biodisponibili e vitamine in forme attive. Ad esempio, fegato, uova, carne, pesce e latticini contengono una gamma completa di nutrienti essenziali, spesso senza la presenza di antinutrienti che ne ridurrebbero l’assimilazione. Anche alcuni alimenti vegetali, come verdure a foglia verde e frutti di bosco, hanno un’elevata densità nutrizionale, ma la loro biodisponibilità può essere limitata dalla presenza di composti inibitori dell’assorbimento.
Avere un’alimentazione basata su cibi ad alta densità nutrizionale permette di massimizzare l’apporto di nutrienti essenziali, supportando energia, salute metabolica, sistema immunitario e longevità, senza introdurre calorie superflue che potrebbero portare a eccesso ponderale e squilibri metabolici.

Biodisponibilità dei Nutrienti
La biodisponibilità rappresenta la quantità di un nutriente che l’organismo è effettivamente in grado di assorbire, trasportare e utilizzare per le sue funzioni vitali. Non tutti i nutrienti ingeriti vengono
automaticamente sfruttati dal corpo: il loro assorbimento dipende da diversi fattori, tra cui la forma chimica del nutriente, la presenza di altri composti che ne facilitano o ne ostacolano l’assimilazione e la salute dell’apparato digerente.
Le proteine e i micronutrienti di origine animale hanno generalmente una biodisponibilità superiore rispetto alle fonti vegetali. Questo è dovuto a diversi motivi:
1. Migliore profilo amminoacidico nelle proteine animali Le proteine di origine animale contengono tutti gli amminoacidi essenziali in proporzioni ottimali per l’organismo umano, rendendole altamente complete e assimilabili. Al contrario, molte proteine vegetali mancano di alcuni amminoacidi essenziali o li contengono in quantità limitanti. Ad esempio, i legumi sono carenti di metionina, mentre i cereali sono poveri di lisina.
2. Minerali in forme più biodisponibili I minerali presenti nei cibi animali sono più facilmente assorbibili rispetto a quelli di origine vegetale. Ad esempio:
– il FERRO EME, contenuto nella carne e nel pesce, viene assorbito con un’efficienza fino al 30%, mentre il ferro non-eme di origine vegetale ha un’assimilazione molto più bassa (2-10%) e viene inibita da sostanze come ossalati e fitati.
– il CALCIO presente nei latticini ha una biodisponibilità maggiore rispetto a quello contenuto nei vegetali, dove è spesso legato a ossalati o fitati, riducendone l’assimilazione.
3. Vitamine in forme attive e pronte all’uso Le vitamine di origine animale sono generalmente presenti in forme già attive, mentre quelle vegetali necessitano di conversioni enzimatiche che variano da persona a persona. Alcuni esempi:
– la VITAMINA A negli alimenti animali (fegato, uova, latticini) è presente come retinolo, immediatamente utilizzabile dal corpo. Nei vegetali, invece, è contenuta sotto forma di beta-carotene, che deve essere convertito in retinolo con un’efficienza molto bassa (stimata tra il 3 e il 10%).
– la VITAMINA B12, essenziale per il sistema nervoso e la produzione di globuli rossi, è assente nei vegetali e si trova solo in carne, pesce, uova e latticini.
4. Assenza di antinutrienti nei cibi animali Gli alimenti di origine vegetale contengono spesso antinutrienti come ossalati, fitati, tannini e lectine, che interferiscono con l’assorbimento di minerali e proteine. Gli alimenti di origine animale, invece, non contengono antinutrienti, garantendo una maggiore efficienza nell’assimilazione dei nutrienti in essi contenuti.
Antinutrienti: ostacoli all’assorbimento
Gli antinutrienti sono composti naturali che possono ridurre l’assorbimento dei nutrienti attraverso due meccanismi principali:
– Legame diretto e sequestro di specifici micronutrienti, rendendoli indisponibili per l’organismo.
– Irritazione e danno della mucosa intestinale, con conseguente ridotto assorbimento generalizzato di molteplici nutrienti.
La maggior parte degli antinutrienti è presente negli alimenti di origine vegetale, motivo per cui i valori nutrizionali di molti cibi vegetali andrebbero ridimensionati alla frazione realmente biodisponibile, considerando il loro impatto.
Per misurare l’effettiva qualità delle proteine e la loro disponibilità biologica, la FAO ha introdotto il DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score). Questo indice considera sia il contenuto di aminoacidi essenziali e semiessenziali, sia la digeribilità dell’alimento, che può essere compromessa dalla presenza di antinutrienti.
Infine, in soggetti predisposti, alcuni antinutrienti potrebbero essere coinvolti in manifestazioni patologiche sistemiche e non solo a livello gastrointestinale.
Principali Antinutrienti e meccanismi d’azione
Gli antinutrienti presenti negli alimenti possono ridurre la disponibilità e l’assorbimento di minerali, vitamine e macronutrienti attraverso diversi meccanismi. Alcuni, come gli ossalati e l’acido fitico, si legano ai minerali formando complessi insolubili che l’organismo non riesce a utilizzare. Altri, come le lectine e gli inibitori delle proteasi, interferiscono con la digestione e l’integrità della mucosa intestinale, compromettendo l’assimilazione dei nutrienti. Esistono poi composti come i tannini e le solanine, che possono influenzare la biodisponibilità di vitamine e minerali o avere effetti irritanti. Di seguito, analizziamo in dettaglio i principali antinutrienti e il loro impatto sulla salute.
Ossalati
Presenti in spinaci, bietole, rabarbaro, cavoli e altre verdure a foglia verde, nonché nei cereali integrali, gli ossalati si legano a minerali come ferro, magnesio e soprattutto calcio, formando complessi insolubili che ne impediscono l’assorbimento. Il loro consumo eccessivo può favorire l’osteoporosi e l’anemia a causa della ridotta disponibilità di minerali essenziali. Inoltre, in soggetti predisposti, l’accumulo di ossalati nel corpo può aumentare il rischio di calcoli renali, in quanto si legano al calcio sierico e formano cristalli nei reni.
Acido Fitico
L’acido fitico, presente in cereali integrali, legumi, noci, mandorle e nocciole (ma praticamente assente nei cereali raffinati), riduce la biodisponibilità di minerali essenziali come ferro, zinco, magnesio, rame e calcio, legandosi a loro e ostacolandone l’assorbimento. Può inoltre interferire con l’assorbimento di proteine e aminoacidi, in particolare quelli con carica positiva, come la lisina.
Tannini
Composti polifenolici presenti in tè, caffè, vino e in alcuni frutti come melograno e bacche, i tannini sono responsabili del tipico sapore astringente di questi alimenti. Interagiscono con le proteine formando complessi insolubili e inibiscono l’assorbimento di ferro, calcio e alcune vitamine.
Lectine
Proteine presenti in legumi e cereali integrali, le lectine possono legarsi alla parete intestinale, danneggiandola e causando infiammazione e disturbi digestivi. Il glutine è un esempio di lectina con effetti potenzialmente problematici. Recenti studi ipotizzano un loro coinvolgimento in patologie sistemiche.
Inibitori delle Proteasi
Queste sostanze inibiscono gli enzimi digestivi coinvolti nella degradazione delle proteine (chimotripsina, tripsina, elastasi), riducendo la disponibilità degli aminoacidi per l’assorbimento intestinale. Sono particolarmente presenti in legumi, patate e cereali.
Glucosinolati
Questi composti si trovano nelle verdure crucifere (cavoletti di Bruxelles, cavoli, broccoli, cime di rapa, rucola, ravanelli, ecc.) e possono sequestrare lo iodio, impedendone l’utilizzo da parte della tiroide. Questo può compromettere la produzione degli ormoni tiroidei (T3 e T4). Soggetti con ipotiroidismo dovrebbero fare particolare attenzione al consumo di questi alimenti.
Fibre
Sebbene il consumo di fibre sia da tempo associato a benefici come il miglioramento del transito intestinale e la prevenzione della diverticolosi, esse possono ostacolare l’assorbimento dei nutrienti. Le fibre si legano ai macronutrienti, rallentandone o impedendone l’assimilazione. È per questo che le fibre abbassano l’indice glicemico degli alimenti. Inoltre, possono causare malassorbimento di micronutrienti come vitamine e minerali. Recenti studi suggeriscono che una riduzione drastica del consumo di fibre potrebbe portare alla scomparsa di sintomi digestivi come gonfiore intestinale e maldigestione, migliorando la regolarità intestinale.
Solanine
Le solanine sono alcaloidi tossici presenti in patate (non nella patata dolce), melanzane, peperoni e pomodori. In quantità elevate possono provocare disturbi neurologici come spossatezza, sonnolenza e ansia, oltre a irritare la mucosa gastrica. Le solanine interferiscono con la vitamina D, inibendone l’azione. o Per ridurne l’assunzione, è consigliabile:
– Rimuovere le parti verdi delle patate (la solanina si concentra nella buccia e nelle parti verdi).
– Scegliere pomodori ben maturi e cuocerli adeguatamente. Consumare melanzane mature e ben cotte.
– Soggetti con patologie autoimmuni dovrebbero fare particolare attenzione a questi composti.
Ridurre l’effetto degli antinutrienti
Diversi metodi di preparazione degli alimenti permettono di ridurre il contenuto di antinutrienti, migliorando la biodisponibilità dei nutrienti e facilitandone l’assorbimento da parte dell’organismo.
L’ammollo è una tecnica efficace per ridurre la presenza di acido fitico, lectine e saponine nei legumi. Lasciarli in acqua per diverse ore permette di eliminare parte di questi composti, rendendoli più digeribili. La fermentazione, utilizzata da secoli per conservare gli alimenti, sfrutta l’attività di batteri e lieviti per disattivare molti antinutrienti. Un esempio è la lievitazione naturale del pane, che abbassa il contenuto di lectine, glutine, acido fitico e inibitori delle proteasi, migliorandone la tollerabilità.
La cottura, in particolare la bollitura e la cottura a vapore, aiuta a denaturare gli antinutrienti proteici, come inibitori delle proteasi e lectine, neutralizzandone gli effetti. Un altro metodo efficace è la germinazione, che induce cambiamenti biochimici nei semi e nei legumi, riducendo gli antinutrienti e aumentando la disponibilità di vitamine e minerali.
Nonostante questi metodi siano utili, è importante sottolineare che non eliminano completamente gli antinutrienti, e quindi il loro consumo è inevitabile in una dieta varia. Inoltre, molti alimenti vegetali vengono consumati crudi o in grandi quantità, specialmente nelle diete vegetariane o vegane, aumentando così l’esposizione agli antinutrienti.
Per chi soffre di infiammazione sistemica, malattie autoimmuni o carenze nutrizionali, può essere utile valutare, sotto la guida di un professionista esperto, regimi alimentari a basso o nullo contenuto di antinutrienti, come la dieta Animal-Based o Carnivore, che escludono gran parte delle fonti vegetali responsabili di queste interferenze nutrizionali.

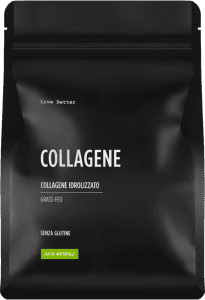
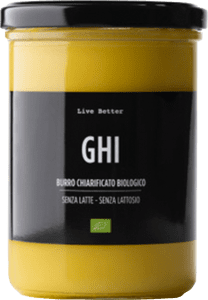



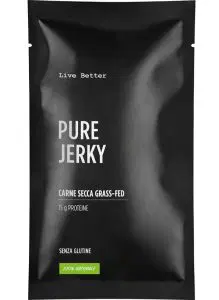













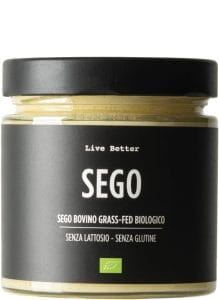

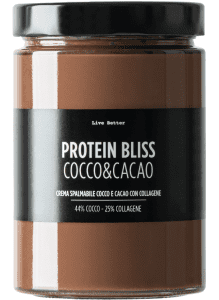
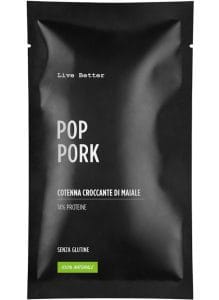







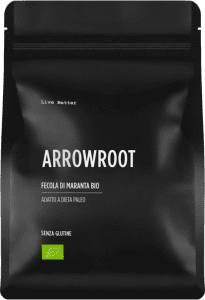







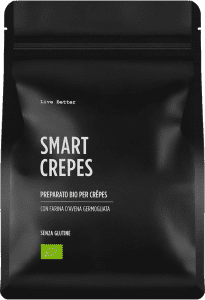




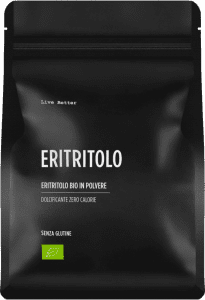

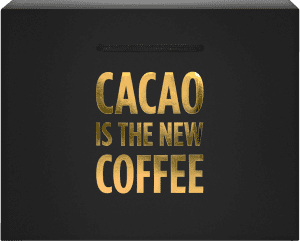



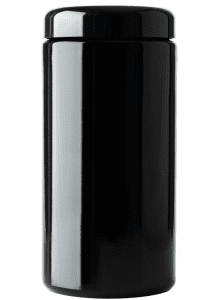






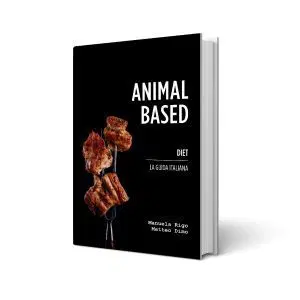








Scrivi un commento