GRASSI SATURI E INSATURI
I grassi sono forse il macronutriente che crea più confusione. Moltissime persone addirittura li temono. Devo ammettere che prima del 2014 anche io li temevo, poi dopo aver approfondito l’argomento ho capito che le mie paure erano totalmente infondate. Quindi desidero iniziare questo approfondimento facendo una premessa: quanto sono importanti i grassi per il benessere del nostro organismo? Spero che possa esservi utile per imparare ad amare i grassi.
LE FUNZIONI DEI GRASSI
I grassi svolgono numerose funzioni fondamentali per il funzionamento ottimale del nostro corpo:
- Produzione di energia: i grassi sono il macronutriente più efficiente che esista: 1 grammo di grasso fornisce 9,45 kcal (arrotondato per convenzione a 9 kcal) mentre proteine e carboidrati ne forniscono meno della metà: 3,75 kcal (per convenzione arrotondato a 4 kcal)
- Riserva energetica: le scorte di carboidrati nel nostro copro (glicogeno) sono 400/500 grammi (1600/2000 kcal). Le riserve di grassi invece sono ampissime e sono quelle che ci hanno permesso di sopravvivere in periodi di carestia. Il glicogeno nel corpo non ci fornisce l’energia necessaria nemmeno per sopravvivere un giorno, mentre le riserve di grasso in una persona molto magra le permetterebbero di sopravvivere anche per 30 giorni senza cibo.
- Funzione strutturale: fosfolipidi e colesterolo (due tipologie di grassi) sono i componenti fondamentali della membrana cellulare di cui regolano la fluidità e la permeabilità. Inoltre sono una componente importante del film idrolipidico che ricopre la pelle e della mielina, la sostanza che ricopre le fibre nervose
- Assorbimento vitaminico: esistono vitamine idrosolubili (solubili in acqua) e liposolubili (solubili in grasso). Una dieta povera di grassi può causare una carenza di queste importanti vitamine:
- Vitamina A:: rientra nei meccanismi di visione notturna, permettendoci di mettere a fuoco e di vedere bene anche in condizioni di scarsa luminosità
- Vitamina D: importante per la formazione ed il mantenimento dello scheletro, per la regolazione ormonale e per il rafforzamento del sistema immunitario. Chi soffre di squilibri endocrini o di patologie autoimmuni è carente di vitamina D: una dieta con pochi grassi peggiora la condizione e i sintomi (1)
- Vitamina E: è un importantissimo antiossidante, tra i più potenti nel nostro corpo
- Vitamina K: interviene nei meccanismi di coagulazione del sangue, una carenza è correlata ad un aumentato rischio di ecchimosi e sanguinamento delle muscose (comprese le gengive)
- Impulsi nervosi: gli impulsi nervosi a livello cerebrale viaggiano grazie alla presenza di grassi insaturi, in particolare il DHA (omega3). I grassi sono fondamentali per il nostro cervello, infatti è stata dimostrata una correlazione tra diete ricche di grassi e prevenzione di patologie neurodegenerative quali Alzheimer e Parkinson; queste diete sono state anche efficaci a rallentare la perdita di funzione cognitiva di persone già affette dal morbo
- Stato emotivo: i grassi sono fondamentali anche per il benessere psicoemotivo: gli studi scientifici stanno indagando questo ramo della nutrizione, scoprendo che le diete povere di grassi predispongono a turbe dell’umore, ansia, ossessioni, tristezza e malinconia
- Regolazione ormonale: il colesterolo nonostante la sua cattiva reputazione è il precursore degli ormoni stereoidei sia maschili che femminili (testosterone, progesterone, estradiolo, cortisolo). Inoltre pensate all’importanza del grasso in una donna: un’eccessiva riduzione del grasso corporeo (al di sotto del 10-12%) è generalmente correlata ad alterazioni del ciclo mestruale (dismennorea, amenorrea) e a problemi di natura ossea (osteoporosi precoce). Se non abbiamo una sufficiente riserva di grasso corporeo il corpo non è in grado di affrontare una gravidanza, per questo il ciclo si arresta.
- Protezione della pelle: Tutta la nostra pelle è ricoperta da un sottile strato lipidico, che permette di difendersi da attacchi esterni di batteri e agenti atmosferici, garantisce una pelle elastica e luminosa, dona morbidezza e idratazione. I grassi infatti sono un caposaldo delle diete anti-aging!
- Protezione da traumi: i grassi proteggono articolazioni ed organi vitali da possibili traumi mantenendoli, tra l’altro, nella loro posizione fisiologica
- Isolamento termico: il grasso interviene nei processi di termoregolazione del nostro corpo (soprattutto il grasso bruno) fungendo da vero e proprio isolante in grado di proteggere l’organismo dalle basse temperature
- Senso di sazietà: i grassi hanno un elevato potere saziante e ritardano l’insorgenza della fame
A questo punto vi siete già innamorati dei grassi vero???
Ma quanti grassi dobbiamo consumare al giorno? I LARN (che sono i Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) consigliano di assumere tra il 20 e il 35% delle calorie giornaliere attraverso i grassi (2).
ATTENZIONE: i grassi contengono il doppio delle calorie rispetto a carboidrati e proteine, quindi per coloro che stanno cercando di dimagrire sarà necessario prestare attenzione alla quantità di grassi consumata.
MACRO E MICRO NUTRIENTI
I macronutrienti sono i principali fornitori di nutrimento per il nostro corpo:
- Glucidi (dal greco glucos, dolce) chiamati anche carboidrati (4 kcal per grammo)
- Protidi (dal greco protos, primario) chiamati anche proteine (4 kcal per grammo)
- Lipidi (dal greco lipos, grasso) chiamati anche grassi (9 kcal per grammo)
I macronutrienti vengono utilizzati dal nostro corpo per funzioni diverse:
- Grassi e carboidrati: fonte di energia
- Proteine: costruzione e mantenimento del nostro corpo
I micronutrienti invece vengono utilizzate dal nostro organismo in numerosissime funzioni fisiologiche:
- Sali minerali (esempio: il magnesio è utilizzato in più di 600 reazioni enzimatiche(3))
- Vitamine
Si definiscono “macro” perché ne assumiamo una quantità maggiore rispetto ai micronutrienti. Infatti per i macronutrienti si utilizza come unità di misura il grammo (g) mentre per i micronutrienti il milligrammo (mg)
Curiosità: sapevo che la parola glucidi (carboidrati) derivasse dal greco glucos (dolce) ma è la prima volta che scopro che proteine derivi da protos (primario). Gli antichi greci erano veramente avanti, avevano già compreso che le proteine sono fondamentali per il nostro organismo e quindi le consideravano primarie. Ricordiamoci che solo due dei macronutrienti sono definiti essenziali: proteine (aminoacidi essenziali) e grassi (omega 3 e omega 6). Non esistono carboidrati essenziali.
MACRONUTRIENTI: COME SONO FATTI
I macronutrienti vengono catalogati in base alla loro struttura chimica:
- Carboidrati: formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno
- Proteine: formate da catene di aminoacidi
- Grassi: formati principalmente da una coda carboniosa (formata da carbonio e idrogeno) e una “testa” (gruppo carbossilico) dove troviamo carbonio, idrogeno e ossigeno.

GRASSI SATURI E INSATURI
So che la distinzione tra grassi saturi e insaturi sembra una questione metafisica, ma in realtà è semplicissima vedrete! Per prima cosa bisogna comprendere che un grasso è composto da tanti tipi di acidi grassi diversi. La maggior presenza di acidi grassi saturi, monoinsaturi o polinsaturi determinerà se il grasso è saturo, monoinsaturo o polinsaturo.
Per esempio l’olio di oliva è composto circa da (4):
- 17% acidi grassi saturi
- 70% acidi grassi monoinsaturi
- 13% acidi grassi polinsaturi
Siccome gli acidi grassi monoinsaturi sono quelli maggiormente presenti, l’olio di oliva viene classificato come grasso monoinsaturo.
Ma cosa sono gli acidi grassi? Molecole formata da una catena carboniosa e da una testa (gruppo carbossilico) Le lettere corrispondono ai seguenti elementi: C = carbonio, O = ossigeno, H = idrogeno

La lunghezza e le caratteristiche della coda carboniosa determinano le caratteristiche chimico fisiche dell’acido grasso. Ma soprattutto ci permetteranno di capire una volta per tutte la distinzione tra grassi saturi e grassi insaturi: basta guardare com’è fatta la sua coda.
Cominciamo con gli acidi grassi saturi: come vedete nella figura ogni atomo di carbonio (lettera C) presente nella coda è legato a due atomi di idrogeno (la lettere H sopra e sotto). Questo tipo di legame viene definito saturo, perché l’atomo di carbonio è legato a due molecole di idrogeno e non si può legare ad altre molecole: quindi le sue possibilità di legarsi sono sature. Questa condizione è energeticamente molto stabile ed è la ragione per cui io amo i grassi saturi (poi vi spiego meglio).

Nella coda del grasso insaturo invece abbiamo un problemino: guardate le due C legate con la doppia riga verde: a entrambe manca un atomo di idrogeno in basso. Questa condizione le obbliga a “legarsi” tra di loro con un doppio legame, che però non è per niente stabile e quindi sono vittime perfette per i radicali liberi, che si legheranno a questi atomi di carbonio ossidando il grasso. E questa è la ragione per cui io non amo i grassi insaturi.
I grassi insaturi si differenziano in:
- monoinsaturi (un solo doppio legame)
- polinsaturo (due o più doppi legami)
I grassi polinsaturi sono ancora più instabili, perché ci sono diversi atomi di carbonio insabili.
La quantità di atomi di carbonio instabili determina la velocità di ossidazione (5) dei grassi:
- grasso saturo = 1
- monoinsaturo = 10
- poliinsaturi = 100
La reazione di ossidazione dei grassi porta alla formazione di odori sgradevoli negli alimenti, quella
che chiamiamo “puzza di rancido”. Le molecole che si formano dall’ossidazione lipidica però non
sono solo puzzolenti ma in molti casi anche tossiche e cancerogene.
NPN nota per nerd
Il numero dopo la C indica da quanti atomi di carbonio è composto l’acido grasso.
Il numero dopo i due punti indica quanti doppi legami sono presenti.
Acido palmitico, C16:0, zero doppi legami, quindi saturo
Acido oleico, C18:1, un doppio legame, quindi monoinsaturo
Acido linoleico, C18:2, due doppi legami, quindi polinsaturo
COME RICONOSCERE GRASSI SATURI E INSATURI
Capire se un grasso è saturo o insaturo è veramente semplicissimo:
- i grassi saturi a temperatura ambiente sono solidi, perché le loro code sono diritte e quindi
si impacchettano ordinatamente formando una struttura solida. - i grassi insaturi invece a temperatura ambiente sono liquidi perché le loro code sono
“piegate” e quindi non possono impacchettarsi.

Grassi saturi (i più stabili)
- burro
- strutto/lardo (grassi di maiale)
- sego (grasso di mucca)
- olio di cocco
- olio di palma
- burro di cacao
Grassi monoinsaturi
(meno stabiii dei saturi, ma più stabili dei polinsaturi)
- olio d’oliva
- olio di avocado
- olio di arachidi
- olio di mandorle
- olio di nocciole
- olio di noci pecan
- olio semi di zucca
- olio di semi di sesamo
Grassi polinsaturi
(i più instabili di tutti)
- olio di soia
- olio di girasole
- olio di noci
- olio di mais
- olio di sesamo
Tra gli acidi grassi polinsaturi ci sono anche omega 3 e 6 che sono acidi grassi essenziali, ovvero dobbiamo obbligatoriamente assumerli con l’alimentazione. Il pesce è molto ricco di questi acidi grassi, ma sono contenuti anche in carne e uova (anche se in misura minore). Se galline e mucche sono allevate secondo natura il livello di omega 3 è più alto. Troppi omega 6 sono infiammatori, quindi attenzione.
Tra i più noti omega 3 abbiamo: EPA e DHA.
ATTENZIONE: nonostante alcune persone affermino il contrario, nei vegetali non ci sono omega 3 e omega 6 ma i loro precursori: ALA acido alfa linolenico e LA acido linolenico. Il problema è che la conversione di ALA in EPA e DHA è molto bassa:
- ALA > EPA: 5%
- ALA > DHA: 0,5%
Gli unici vegetali che contengono EPA e DHA sono le alghe, ma la quantità è molto bassa, quindi è difficile che possano fornire il quantitativo necessario.
OSSIDAZIONE E ROS
Perché io (ma non solo io) amo i grassi saturi e non amo i grassi insaturi? Sono cinquant’anni che ci dicono che i grassi saturi sono il male supremo e dobbiamo sostituirli con i grassi insaturi, eppure io faccio l’esatto opposto di quanto suggerito dalle linee guide. Come mai?
La risposta è molto semplice e ha a che fare con la velocità di ossidazione dei diversi grassi (5):
grasso saturo = 1
monoinsaturo = 10
poliinsaturi = 100
(sono valori esemplificativi non effettivi, solo per illustrare le differenze abissali)
L’ossidazione dei grassi genera odori sgradevoli (puzza di rancido) e in alcuni casi anche sostanze tossiche e cancerogene.
Ma cos’è questa ossidazione di cui spesso sentiamo parlare? L’ossidazione è la reazione che avviene quando un atomo/sostanza, come un radicale libero, ruba un elettrone a un altro atomo/sostanza. Gli antiossidanti contrastano l’ossidazione perché hanno un elettrone disponibile e lo donano al radicale libero.

I ROS (Reactive Oxigen Species) chiamati in italiano “specie reattive dell’ossigeno” sono i radicali liberi più diffusi nel nostro corpo. I radicali liberi sono molecole a cui manca un elettrone e quindi lo vanno a cercare “ossidando” altre molecole.
Che effetto hanno i ROS nel nostro corpo? Compromettono la funzionalità delle proteine, danneggiano il DNA e ossidano i grassi. Le molecole più suscettibili all’attacco dei radicali liberi sono i grassi. I fattori che favoriscono l’ossidazione sono principalmente ossigeno, calore e luce, ma anche metalli, azioni enzimatiche e microrganismi.
Quando si crea sovrabbondanza di radicali liberi nel nostro sistema, questi cominciano ad attaccare in modo massico le nostre cellule causandone l’invecchiamento, che favorisce l’insorgere di malattie più o meno gravi.
Possiamo proteggerci dall’ossidazione? Sì e no: una delle fonti principali di ROS è la produzione di energia da parte dei mitocondri, quindi qualcosa di cui non possiamo fare decisamente a meno. Altre fonti sono lo stress, l’infiammazione, l’inquinamento, il fumo, l’attività fisica troppo intensa e molte sostanze farmacologiche. E qui ci possiamo sicuramente lavorare.
Il nostro corpo produce autonomamente enzimi e antiossidanti in grado di neutralizzare i radicali liberi, ma anche noi possiamo aiutarlo:
- introducendo antiossidanti con l’alimentazione (il cacao in polvere è in assoluto uno degli alimenti più ricchi di antiossidanti)
- cercando di tenere bassa l’infiammazione
- evitando di consumare troppi grassi polinsaturi instabili (facilmente ossidabili)
- fornendo al nostro corpo la glicina necessaria alla produzione del glutatione, uno degli antiossidanti più potenti prodotti dal nostro corpo. In questo studio (7) si dimostra che la quantità di glicina introdotta con l’alimentazione determina la quantità di glutatione producibile dal nostro corpo. Questo studio è una delle ragioni per cui ho deciso di assumere collagene e quindi di venderlo in Live Better. Il collagene infatti è l’alimento in assoluto più ricco di glicina.
- evitando di fumare
- evitando di essere costantemente stressati
GRASSI IDROGENATI E TRANS FAT
Finora abbiamo parlato di grassi che si trovano in natura. Un discorso a parte va fatto per i grassi creati dall’uomo: i grassi idrogenati. Siccome gli oli polinsaturi irrancidiscono velocemente l’essere umano ha pensato bene di idrogenarli per poterli conservare più a lungo.

Come funziona il processo di idrogenazione dei grassi polinsaturi Vi ricordate il doppio legame degli grassi polinsaturi? A ciascuno dei due atomi di carbonio uniti dal doppio legame manca un atomo di idrogeno in basso e il processo di idrogenazione non fa altro che fornirglielo. In questo modo la coda si “raddrizza” e come per magia l’olio diventa solido: un esempio è la margarina, che è composta da un olio polinsaturo che è stato idrogenato e quindi è diventato solido.
Problemino: dopo aver invitato la popolazione a sostituire quel cattivone del burro (pieno di grassi saturi) con la margarina negli anni ’80 ci siamo resi conto che il processo di idrogenazione creava i trans fat (grassi trans) che oggi sappiamo essere responsabili di: malattie coronariche, ateriosclerosi (e quindi infarto) e ictus cerebrale. (8,9,10)
Per questo motivo nel 2015 la FDA (Food and Drug Administration l’agenzia americana preposta alla sicurezza alimentare) ha vietato la presenza di grassi trans negli alimenti a partire da giugno 2018. In Europa i grassi trans sono ancora ammessi negli alimenti entro il limite di 2 grammi su 100 grammi di grasso totale. Sui grassi l’America è sempre stata più avanti di noi: pensate che già dal 2006 era obbligatorio riportare nella tabella nutrizionale il contenuto dei grassi trans. Da noi non lo è nemmeno adesso 17 anni dopo…
Solitamente l’EFSA, (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) è più severa dell’FDA, come mai in questo caso no? C’è una bellissima storia dietro, il cui protagonista è il Prof. Fred A. Kummerow, un vero change-maker (una persona che cambia le cose).
Negli anni 50, ancora ricercatore universitario, Kummerow convince un ospedale locale a fargli esaminare le arterie di pazienti deceduti per malattie cardiache. Con sua sorpresa trovò nei tessuti grandi quantità di grassi trans, che allora si trovavano in quasi tutti i cibi confezionati.
In seguito dimostrò che i topi che venivano nutriti con grassi trans (grassi trans) sviluppavano ateriosclerosi e che questa spariva quando veniva rimossi i grassi trans dall’alimentazione.
Pubblicò la sua prima ricerca sul legame tra i grassi trans e l’ateriosclerosi nel 1957. Ma nonostante l’evidenza che continuò ad accumulare nel corso di decenni, il suo allarme rimase inascoltato.
Finalmente negli anni 90 qualcosa iniziò a muoversi: nel 1995 un’associazione richiese all’FDA che il contenuto di grassi trans fosse riportato nella tabella nutrizionale, cosa che avvenne solo nel 2006. L’opinione pubblica però era ormai a conoscenza dei pericoli legati al consumo di grassi trans e quindi le aziende alimentari cominciarono a eliminarli volontariamente da alcune ricette. Però non era sufficiente perché i grassi trans restavano presenti ancora in tantissimi prodotti.
Frustrato dalla situazione nel 2009 Kummerow, all’età di 94 anni, presenta un’istanza all’FDA richiedendo che i grassi trans venissero eliminati dall’alimentazione degli americani.
Nel 2013 non avendo avuto risposta dall’FDA Kummerow (all’età di 98 anni!!!) decide di optare per le maniere forti: fa causa all’FDA e al dipartimento della salute americano e magicamente tre mesi dopo l’FDA annuncia i suoi piani di eliminare i grassi trans in quanto non considerati sicuri per la salute umana. Da giugno 2018 le industrie alimentari americane non possono più utilizzare i grassi trans.
Fred Kummerow è stato un uomo straordinario che ha lottato fino all’ultimo per cambiare le cose. È morto a 102 anni e ha continuato a lavorare nel suo laboratorio fino all’età di 101 anni. Oltre alla sua lotta contro i grassi trans, ha anche contribuito a scoprire che è il vero colpevole del rischio cardiovascolare è il colesterolo ossidato. Guardatelo, anche lui aveva la luce negli occhi.

Attenzione: la definizione di grassi trans considerati nocivi è molto tecnica ed esclude i grass trans presenti nel latte materno, nei latticini e nella carne di manzo, come per esempio l’acido vaccenico di cui abbiamo parlato nell’approfondimento “la carne rossa causa il cancro?”. Qui abbiamo parlato di un recentissimo studio (11) dove è emerso che l’acido vaccenico migliora l’abilità del linfocita CD8+ T di infiltrare e uccidere le cellule cancerogene. Analizzando pazienti malati di tumore, quelli con i più alti livelli di acido vaccenico nel sangue hanno risposto meglio all’immunoterapia. Acido vaccenico… il nome vi ricorda qualcosa? Si trova nella carne e nel latte dei ruminanti: vacche, pecore, capre, etc. E si trova anche nel latte umano.
PUNTO DI FUMO
Un altro aspetto fondamentale da toccare in merito ai grassi è il punto di fumo, ovvero la temperatura a cui un olio comincia il processo di degradazione ossidativa per cui rilascia sostanze volatili visibili, come il fumo, e forma una sostanza tossica chiamata acroleina. I grassi più adatti per la cottura sono quindi quelli con elevato punto di fumo, che conferisce buona stabilità alle alte temperature.
Chiaramente la scelta del grasso appropriato dipende dal tipo di cottura che si deve effettuare. La frittura (dove l’alimento è completamente immerso nel grasso) ha temperature molto alte e quindi dovremo scegliere un grasso con un punto di fumo maggiore di 200 °C (per questo l’olio di oliva non va bene per friggere). Se dobbiamo semplicemente saltare in padella un alimento, le temperature raggiunte non saranno alte come in frittura e quindi potremo utilizzare anche un grasso con punto di fumo inferiore a 200°C.
Per stilare questa classifica ho dovuto consultare diverse fonti (12,13,14,15). Purtroppo non c’è un dato ufficiale su questo importantissimo parametro. I dati si riferiscono ai grassi nel loro stato naturale, quindi non raffinati e non frazionati.
- Burro chiarificato, ghi: 250°C
- Sego di manzo: 250°C
- Lardo: 240°C
- Olio di girasole alto oleico: 225°C
- Olio di avocado: 200°C
- Olio di oliva extra vergine: 190°C
- Olio di cocco: 180°C
Evito di segnalare altri grassi perché secondo me questi dovrebbero essere gli unici utilizzati. Chiaramente se voi volete utilizzarne altri siete liberissimi di farlo, ma io non me la sento di consigliarli.
Chiaramente ci sarà una seconda puntata di questo approfondimento sui grassi che andrà a indagare la storia dietro alla condanna dei grassi saturi. Vi anticipo che non ha alcun fondamento scientifico e ci sono numerosissimi medici e ricercatori che affermano che la questione “grassi saturi e colesterolo” sia una delle più grandi truffe subite dal genere umano.
Se volete approfondire l’argomento colesterolo ci sono tre bellissimi approfondimenti da leggere sul nostro sito che sono la traduzione di tre straordinarie lezioni del dottor Paul Mason, da leggere in questo ordine.
- L’oscura storia delle statine
- Perché il vostro medico pensa che il colesterolo faccia male
- La verità sul colesterolo alto (qui viene spiegato perché il “trigliceridi : HDL” sia il miglior dato per valutare il rischio cardiovascolare)
Buona lettura! E ricordate: la conoscenza rende liberi!
BIBLIOGRAFIA
- https://www.alimentazioneinequilibrio.com/le-funzioni-dei-grassi/
- https://sinu.it/2019/07/09/lipidi/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25540137/
- https://www.researchgate.net/figure/Fatty-acid-composition-of-the-extra-virgin-olive-oilsfrom-Grossa-di-Gerace-cv_tbl2_274141711
- Dispensa “Chimica degli alimenti. I lipidi” del corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari seguito dalla dottoressa Manuela Rigo
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17622276/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5855430/
- https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)04166-0/fulltext
- https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra054035
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ana.23555
- https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Smoke_point_of_cooking_oils
- https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Smoke_point_of_cooking_oils
- https://www.foodnz.co.nz/uploads/articlespdfs/FryingOils.pdf
- https://thrive-magazine.co.uk/the-smoke-point/
- https://actascientific.com/ASNH/pdf/ASNH-02-0083.pdf
- https://ilfattoalimentare.it/chimica-frittura-segretiolio.html#:~:text=Reciprocamente%2C%20il%20punto%20di%20fumo,cocco%20(195%20%C2%B0C).
- https://ilfattoalimentare.it/olio-di-girasole-confronto.html

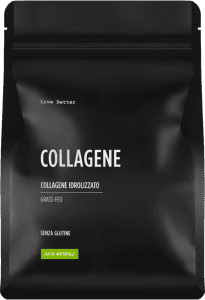
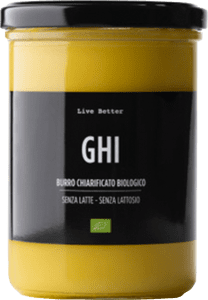



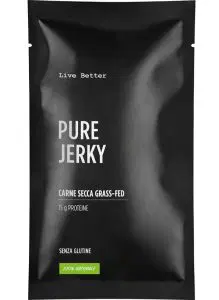






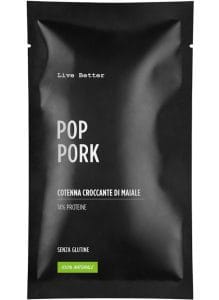

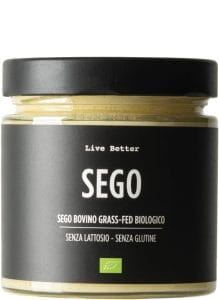

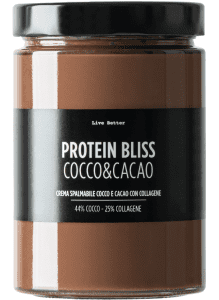







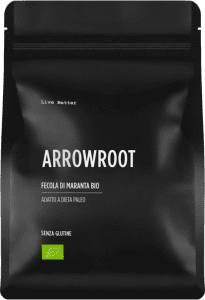







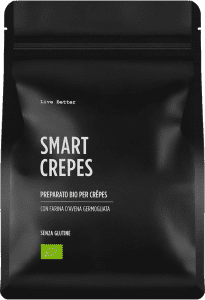




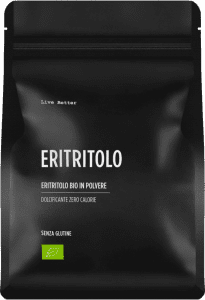

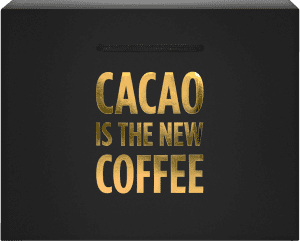


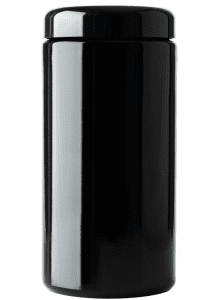










Scrivi un commento